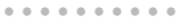
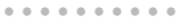

Psicoide e protomentale: Jung e Bion
di Riccardo Gramantieri ed Erica Neri
Le formulazioni del concetto di inconscio, in Jung e in Bion, sono complesse e affascinanti e al di là della loro indubbia originalità, hanno punti di contatto. Carl Gustav Jung (1875-1961), legato a Freud per un certo periodo della propria vita professionale, elabora la propria psicologia analitica in maniera autonoma dal maestro viennese, malgrado alcune intuizioni comuni nate durante lo studio delle associazioni verbali. Wilfred Bion (1897-1979) affonda le proprie radici nel pensiero freudiano e deriva il proprio lavoro dalla teoria delle relazioni oggettuali di Melanie Klein. Jung e Bion, appartenenti a momenti diversi della storia psicoanalitica, sono ovviamente autonomi nel proprio lavoro teorico, per cui non si evidenziano collegamenti diretti. Bion arriva alla psicoanalisi attraverso gli studi di medicina e il successivo lavoro con i gruppi in ambito militare, e l'unico labile collegamento con il pensiero junghiano è riscontrabile come interesse culturale, quando nel 1935 consigliò al suo illustre paziente, Samuel Beckett, di ascoltare una conferenza che Jung teneva alla clinica Tavistock (Bléandonu, 1990). È possibile, tuttavia, riscontrare, nei due Autori, l'interesse per il funzionamento psicotico e la messa a punto di una tecnica rivolta all'hic et nunc piuttosto che al passato. È possibile inoltre pensare ad alcune ulteriori analogie fra alcuni concetti cardine, quali l'inconscio interpersonale, il processo di trasformazione da inconscio a conscio attuato durante la seduta, e l'ipotesi di concomitanza di significati fra elementi psicofisici.
L'inconscio collettivo in Jung
Jung, proseguendo alcuni studi compiuti da Eugen Bleuler, compie i primi esperimenti associativi su persone "normali" durante lo svolgimento della sua professione presso la clinica psichiatrica Burghölzli di Zurigo, e pubblicherà la metodologia dell'esperimento ed i risultati nel 1904. A questi primi studi segue l'applicazione del metodo alle persone affette da dementia praecox, patologia che rappresenta il primo campo di studi e di interesse di Jung. Gli esperimenti di associazione permettono di rilevare l'esistenza di complessi. Nel saggio Sulla dottrina dei complessi (1911), Jung definisce il complesso come un tema personale costituito da varie idee tenute assieme da un tono emotivo e che, in particolari condizioni, può esercitare un influsso patogeno. Esso è il «polo di attrazione delle rappresentazioni [ed ha] capacità di azione autonoma nella mente, indipendente dalla coscienza» (Innamorati, 2013, p. 53). Il complesso è relativamente indipendente dal controllo centrale della coscienza ed è capace in qualsiasi momento di condizionare e contrastare le intenzioni dell'individuo grazie alla sua autonomia, proprietà che permette la prevaricazione dell'autocontrollo.
Nelle persone "normali", il complesso dell'Io, grazie al suo collegamento diretto con le sensazioni corporee, è il più stabile e il più ricco di associazioni; negli schizofrenici l'attività psichica è invece in balia di altri complessi, particolarmente forti, quali quelli della Madre e del Padre. Essi occupano un posto di primo piano e padroneggiano i pazienti in modo assoluto, per cui essi parlano, agiscono e sognano solo secondo quanto suggerito da tali complessi (Jung, 1907).
Al centro del complesso c'è un tono emotivo, poi ridefinito archetipo, termine che Jung riprende da De opificio mundi del filosofo ebreo-ellenico Filone d'Alessadria (Jung, 1934-54). Gli archetipi sono universali, latenti e inconsci, sono cioè tracce mnestiche provenienti dal passato ancestrale dell'uomo, accumulatesi in seguito alle continue ripetizioni di esperienze di infinite generazioni, e contenenti immagini mitologiche ereditate con la struttura cerebrale (Magnanensi, 1974). Il loro insieme costituisce l'inconscio collettivo (o psicoide), di cui fanno parte anche gli istinti (Shamdasani, 2003). Come ogni uomo possiede degli istinti, così possiede anche immagini originarie. Le prove di quest'affermazione sono offerte in primo luogo dalla psicopatologia di quei disturbi mentali nei quali si manifesta l'inconscio collettivo. Nella schizofrenia si assiste infatti all'emergere di impulsi arcaici associati ad immagini inconfondibilmente mitologiche (Jung, 1919). Lo psicoide esercita dunque un'azione sulla persona, attraverso l'emergere di idee chiamate complessi al cui centro vi è l'archetipo; esso è pertanto il deposito di tutte le esperienze umane fin dai più oscuri primordi (Jacobi, 1959). Un archetipo «sorge in quanto coincide con una maniera consolidata o abituale di affrontare delle situazioni critiche; quando, nella vita, si presenta una crisi, viene costellato questo o quell'archetipo: è una specie di meccanismo o di atteggiamento tipico per mezzo del quale si risolvono problemi tipici» (Jung, 1934-1935, p. 25). Esso non è una rappresentazione, ma una possibilità di rappresentazione ereditata alla quale ricorrere (Jacobi, 1959). Quando il materiale grezzo dell'inconscio collettivo entra in relazione con la coscienza e con la sua proprietà modellatrice, l'archetipo emerge e prende corpo, diventando un'immagine sensibile, cioè rappresentabile (Jacobi, 1959). Gli archetipi, eredità filogenetica e parte di un ordine biologico delle funzioni mentali, costituiscono pertanto un modello determinato che possediamo alla nascita (Jung, 1964), allo stregua dello schema di comportamento di un animale che, appena nato, sa già come muoversi. Essi sono l'aspetto psichico della struttura cerebrale in quanto si ereditano con essa (Jacobi, 1959); sono «manifestazioni autonome degli strati più profondi della psiche [che] necessariamente ha luogo al di là dell'Io e della coscienza. [...]